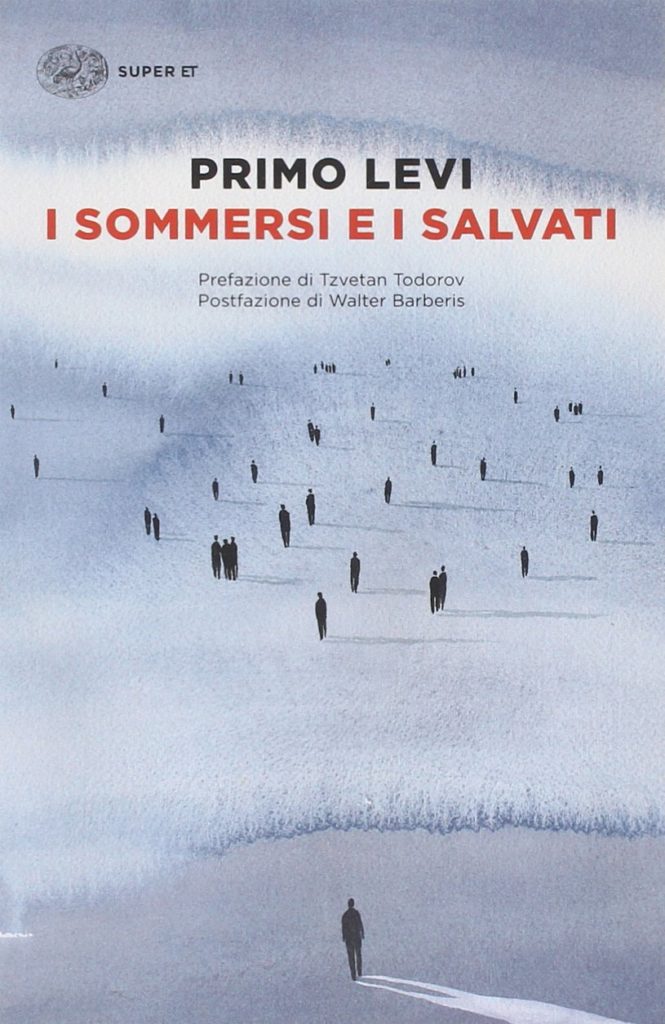Primo Levi, partigiano antifascista, il 13 dicembre 1943 venne arrestato dai fascisti in Valle d’Aosta, venendo prima mandato in un campo di raccolta a Fossoli e, nel febbraio dell’anno successivo, deportato nel campo di concentramento di Auschwitz in quanto ebreo. Scampato al lager, tornò in Italia, dove si dedicò con impegno al compito di raccontare le atrocità viste e subite.
Nella camera a gas sono stati stipati ed uccisi componenti di un convoglio appena arrivato, e la Squadra sta svolgendo il lavoro orrendo di tutti i giorni, districare il groviglio di cadaveri, lavarli con gli idranti e trasportarli al crematorio, ma sul pavimento trovano una giovane ancora viva. L’evento è eccezionale, unico; forse i corpi umani le hanno fatto barriere intorno, hanno sequestrato una sacca d’aria che è rimasta respirabile. Gli uomini sono perplessi; la morte è il loro mestiere di ogni ora, la morte è una consuetudine, poiché, “si impazzisce il primo giorno oppure ci si abitua”, ma quella donna è viva. La nascondono, la riscaldano, le portano brodo di carne, la interrogano: la ragazza ha sedici anni, non si orienta nello spazio né nel tempo, non sa dov’è, ha percorso senza capire la trafila del treno sigillato, della brutale selezione preliminare, della spogliazione, dell’ingresso nella camera da cui nessuno è uscito vivo. Non ha capito, ma ha visto; perciò deve morire, e gli uomini della Squadra lo sanno, così come sanno di dovere morire essi stessi e per la stessa ragione.
Coloro che hanno sperimentato la prigionia (e, molto più in generale, tutti gli individui che hanno attraversato esperienze severe) si dividono in due categorie ben distinte, con rare sfumature intermedie: quelli che tacciono e quelli che raccontano. Entrambi obbediscono a valide ragioni: tacciono coloro che provano più profondamente quel disagio che per semplificare ho chiamato «vergogna», coloro che non si sentono in pace con se stessi, o le cui ferite ancora bruciano. Parlano, e spesso parlano molto, gli altri, obbedendo a spinte diverse. Parlano perché, a vari livelli di consapevolezza, ravvisano nella loro (anche se ormai lontana) prigionia il centro della loro vita, l’evento che nel bene e nel male ha segnato la loro esistenza intera. Parlano perché sanno di essere testimoni di un processo di dimensione planetaria e secolare. Parlano perché (recita un detto jiddisch) «è bello raccontare i guai passati»; Francesca dice a Dante che non c’è «nessun maggior dolore / che ricordarsi del tempo felice / nella miseria», ma è vero anche l’inverso, come sa ogni reduce: è bello sedere al caldo, davanti al cibo ed al vino, e ricordare a sé ed agli altri la fatica, il freddo e la fame: così subito cede all’urgenza del raccontare, davanti alla mensa imbandita, Ulisse alla corte del re dei Feaci. Parlano, magari esagerando, da «soldati millantatori», descrivendo paura e coraggio, astuzie, offese, sconfitte e qualche vittoria: così facendo, si differenziano dagli «altri», consolidano la loro identità con l’appartenenza ad una corporazione, e sentono accresciuto il loro prestigio.
Ma parlano, anzi (posso usare la prima persona plurale: io non appartengo ai taciturni) parliamo, anche perché veniamo invitati a farlo. Ha scritto anni fa Norberto Bobbio che i campi di annientamento nazisti sono stati « non uno degli eventi, ma l’evento mostruoso, forse irripetibile, della storia umana». Gli altri, gli ascoltatori, amici, figli, lettori, od anche estranei, lo intuiscono, al di là della indignazione e della commiserazione; capiscono l’unicità della nostra esperienza, o almeno si sforzano di capirla. Perciò ci sollecitano a raccontare e ci pongono domande, talvolta mettendoci in imbarazzo: non sempre è facile rispondere a certi perché, non siamo storici né filosofi ma testimoni, e del resto non è detto che la storia delle cose umane obbedisca a schemi logici rigorosi. Non è detto che ogni svolta segua da un solo perché: le semplificazioni sono buone solo per i testi scolastici, i perché possono essere molti, confusi fra loro, o inconoscibili, se non addirittura inesistenti. Nessuno storico o epistemologo ha ancora dimostrato che la storia umana sia un processo deterministico.
L’esperienza di cui siamo portatori noi superstiti dei Lager nazisti è estranea alle nuove generazioni dell’Occidente, e sempre più estranea si va facendo a mano a mano che passano gli anni. Per i giovani di questi anni sono cose lontane, sfumate, «storiche». Per noi parlare con i giovani è sempre più difficile. Lo percepiamo come un dovere, ed insieme come un rischio: il rischio di apparire anacronistici, di non essere ascoltati. Dobbiamo essere ascoltati: al di sopra delle nostre esperienze individuali, siamo stati collettivamente testimoni di un evento fondamentale ed inaspettato, fondamentale appunto perché inaspettato, non previsto da nessuno. E avvenuto contro ogni previsione; è avvenuto in Europa; incredibilmente, è avvenuto che un intero popolo civile, appena uscito dalla fervida fioritura culturale di Weimar, seguisse un istrione la cui figura oggi muove al riso; eppure Adolf Hitler è stato obbedito ed osannato fino alla catastrofe. È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire.
Può accadere, e dappertutto. Non intendo né posso dire che avverrà; è poco probabile che si verifichino di nuovo, simultaneamente, tutti i fattori che hanno scatenato la follia nazista, ma si profilano alcuni segni precursori. La violenza, «utile» o «inutile», è sotto i nostri occhi: serpeggia, in episodi saltuari e privati. Attende solo il nuovo istrione (non mancano i candidati) che la organizzi, la legalizzi, la dichiari necessaria e dovuta e infetti il mondo. Occorre quindi affinare i nostri sensi, diffidare dai profeti, dagli incantatori, da quelli che dicono e scrivo no «belle parole» non sostenute da buone ragioni.

Lettura e interpretazione di Giancarlo Mariottini.